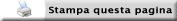|
 RUGGIERO D’ALTAVILLA, DUCA DI PUGLIE E CALABRIE E FONDATORE DELLA MONARCHIA MERIDIONALE RUGGIERO D’ALTAVILLA, DUCA DI PUGLIE E CALABRIE E FONDATORE DELLA MONARCHIA MERIDIONALE
Alla morte in Salerno, nel 1129,del normanno Guglielmo, Duca delle Puglie, senza figli, il Gran Conte R u g g i e r o d ’ Al t a v i l l a, suo cugino, che era in Sicilia, venne presto in detta città e, senza attendere l’investitura papale, si fece quivi dal Vescovo di Capaccio consacrare Principe di Salerno. Passò quindi a Reggio, dove fu proclamato Duca di Puglie e Calabrie, e poi si recò nelle altre province del Mezzogiorno, che tutte lo accolsero come successore di Guglielmo e loro legittimo sovrano.
Onorio Pp. II, sdegnato per il non avere Ruggiero atteso la sua investitura, gli fulminò per ben tre volte la scomunica, ma Ruggiero, con lui scusatosene, gli giurò la solita fedeltà e gli promise il solito censo. Così ne ottenne la solenne investitura, ma non oltre il Ducato di Puglie e Calabrie.
Ruggiero, ormai signore di tante province, lasciato quello di Gran Conte, assunse il titolo di Re di Sicilia, del Ducato di Puglie e Calabrie e del Principato di Capua. Elesse per sua residenza e capitale del Regno Palermo e qui, alla presenza dei Baroni, di molti Vescovi, di tutta la nobiltà e del popolo, si fece da quattro Arcivescovi incoronare Re con tutta la solita ritualità e la più splendida magnificenza. Fu quindi, a giusto titolo, ritenuto dagli storici come il fondatore della monarchia meridionale e primo Re delle due Sicilie.
Questa globale investitura Ruggiero non potè ottenerla da Papa Onorio, il quale nel frattempo era morto. Suoi successori erano stati eletti, nel 1130, contrapposti, ben due Pontefici. Innocenzo Pp. II e Anacleto Pp. II. Anacleto era entrato in carica a Roma e Innocenzo s’era rifugiato in Francia.
Fu quindi Anacleto II che, con sua Bolla, investì Ruggiero ampiamente della Sicilia, delle Puglie, delle Calabrie, del Principato di Capua e del Ducato di Napoli, sebbene i due ultimi Stati fossero ancora in possesso dei rispettivi Principe e Duca. In questa investitura non fu compreso il Principato di Salerno, sul quale il Papato avanzava proprie pretese. Allorché Anacleto fu dichiarato Antipapa, non si poteva porre in dubbio la buona fede di Ruggiero nell’averlo ritenuto Papa legittimo, perché, essendo stati in uno stesso giorno eletti Pontefici da due opposti partiti Anacleto II e Innocenzo II, c’era chi riteneva legittimo Pontefice il primo, chi invece il secondo.
Comunque, nel 1131, Amalfi fu annessa al Regno di Sicilia da Ruggiero, senza che fosse fatto alcun riferimento ai suoi altri domini continentali.
Intanto, Innocenzo Pp. II s’era recato in Germania al fine di convincere l’Imperatore Lotario a venire in Italia per espellere Ruggiero dalle suddette province. Lotario, che nel 1132 lo aveva
riconosciuto e imposto quale legittimo Papa, esautorando Anacleto II, s’indusse a recuperare quelle province, che riteneva essere state a lui sottratte, in quanto Imperatore d’Occidente. Vennero così Innocenzo e Lotario nel 1133 a Roma e Lotario vi fu incoronato Imperatore e Re del Romani; a loro si unirono molti Baroni pugliesi e con essi il Conte Rainulfo di Airola, il Conte Roberto di Capua e il Duca Sergio di Napoli. Dopo vari combattimenti dall’esito incerto, alla fine fu Ruggiero a risultare vincitore. Entrambi sconfitti, Lotario se ne ritornò in Germania e il Papa, scacciato da Roma, si ritirò a Pisa, la ribellione dei Baroni pugliesi fu duramente repressa. Quindi Ruggiero volse tutto il suo impegno contro Napoli e Capua. Quest’ultima città fu ben presto vinta nel 1134 e Ruggiero se ne impossesso insieme con tutte le altre località del Principato.
Il detronizzato Roberto di Capua corse in Germania, per sollecitare, anche a nome del Papa, l’Imperatore a ritornare in Italia. Nel 1136 Lotario III scese in Itala e, dopo aver liberato Torino dalla soggezione signorile di Amedeo III si spinse fin nelle Puglie. Soggiogata Teramo, con molte altre località abruzzesi, prese, in Capitanata, l’antica città di S i p o n t o e tutte le altre città pugliesi fino a B a r i si arresero a lui. Aiutato da Innocenzo, occupò S. Germano. Roberto fu rimesso nel Principato di Capua e i Beneventani presto si arresero anche loro. Rainulfo fu creato Duca delle Puglie e ne ebbe doppia investitura da Lotario e Innocenzo. Ruggiero teneva intanto ben stretta da assedio Napoli, ma quando giunsero in soccorso d’essa i Pisani con cento legni armati, tolse l’assedio. Poi 46 di queste galere andarono a espugnare Amalfi, Scala e Ravello e tutte queste città caddero sotto il dominio di Lotario.
Rimaneva a questi da espugnarsi Salerno. A farlo si aggiunsero Sergio, Roberto e Rainulfo. Dopo un lungo assedio e una vigorosa resistenza Salerno cadde. La sola rocca, dove molti dei difensori s’erano rifugiati, insieme coi loro Baroni e Capitani, non fu espugnata e rimase fedele al suo Re.
Il Papa e l’Imperatore credettero d’aver tutto risolto. Quindi, lasciando Rainulfo con molti ufficiali pontifici e imperiali a far fronte a Ruggiero, se mai fosse tornato a combattere, partirono alla volta di Roma, donde Lotario ritornò in Germania. Ruggiero, però, si preparò alla rivincita e, costretto a cedere a quell’irresistibile impeto, seppe aspettare tempi migliori.
Essi in effetti giunsero. Gli arrivarono notizie che Lotario III era morto nel 1137 nel Tirolo, che gli era succeduto Corrado II di Svevia-Hohenstaufen, eletto contro la candidatura di Enrico il Superbo, genero di Lotario, guelfo e Duca di Biaviera e Sassonia, e che era iniziata una guerra tra i Guelfi e gli Hohenstaufen.
Venne quindi Ruggiero dalla Sicilia con un’imponente armata; giunse a Salerno e la città e le terredei dintorni subito gli si arresero. Il primo assalto fu poi contro Capua, che Ruggiero prese e saccheggiò in odio a Roberto. Benevento gli si arrese e così fece anche Montesarchio. Di là Ruggiero passò nelle Puglie e combatté aspramente contro il Duca Rainulfo. Inutili furono varie trattative di pace, sia col Duca che col Pontefice, malgrado la solerte mediazione di S. Bernardo da Chiaravalle. A Innocenzo Pp. II non restò che scomunicare in Concilio nuovamente Ruggiero e tutti coloro che avevano seguito il partito di Anacleto. Poco tempo dopo morì anche il Duca delle Puglie.
Mentre Ruggiero faceva rapidi progressi in Capitanata, Innocenzo volle imitare Leone Pp. IX e si mise alla testa dell’esercito, col quale da Roma si portò a S. Germano. Ruggiero, prima di affrontarlo, volle un incontro col Papa, sperando di ottenere la pace. Nulla fu concluso, essendosi il Pontefice ostinato a voler ridare Capua a Roberto, la qual cosa fu da Ruggiero negata. Si venne alle ostilità e Innocenzo, sconfitte e messe in fuga le sue truppe, rimase prigioniero insieme con molti Cardinali e altri ragguardevoli personaggi. Ruggiero lo trattò con sommo onore come Vicario di Cristo, anzi implorò il suo perdono e lo pregò vivamente di riappacificarsi con lui. Innocenzo, commosso da tanta generosa devozione, aderì alla domanda e la pace fu in quattro giorni conchiusa. Il Papa assolvette Ruggiero e tutti i suoi aderenti dalle scomuniche e – correva l’anno 1139 – lo investì pienamente della Sicilia, del Ducato pugliese e del Principato di Capua e lo riconobbe legittimo Re, confermandogli tutti gli onori regi attribuitigli. Dal canto loro Ruggiero e il suo omonimo figlio, che poi premorì al padre, gli resero umilmente omaggio, lo riconobbero per legittimo Pontefice e giurarono fedeltà a lui e ai suoi successori. Si resero a lui l i g i, promettendogli il censo di 600 ‘schifati’ annui e la restituzione alla S. Sede della città di Benevento.
I Napoletani, che avevano perduto il loro Duca Sergio in battaglia, si sottomisero volentieri nello stesso anno al dominio di Ruggiero ed elessero loro nuovo Duca il di lui figlio Ruggiero. Furono ai Napoletani lasciati, con le loro leggi, i magistrati, le prerogative e i privilegi che avevano sotto gli ultimi loro Duchi. Ma ciò non riguardava l’amministrazione della giustizia, poiché la giurisdizione il Re volle sempre a sé riservata. Ruggiero si recò ben due volte personalmente a Napoli, vi fece coniare nuove monete, fra le quali una d’argento, che dal Ducato della città fu detta ‘ducato’: si ebbe essa come il denominatore della ricchezza nazionale e il determinatore decimale di ogni somma. Qui attese egli a recuperare alcune terre non ancora sottomesse e punì severamente alcune città e persone inescusabilmente infedeli e ribelle. Così pacificato tutto il Paese, nell’anno 1142 tutte le province dall’Abruzzo ulteriore al Faro rimasero stabilmente unite inun solo Regno, sottoposte a un unico Re con la Sicilia.
Le leggi in uso in queste province ‘continentali’ erano le longobarde, che mai penetrarono per la loro osservanza in Sicilia, dato che quell’isola mai era stata sottoposta ai Longobardi. I Normanni le lasciarono intatte e le vollero osservate. Le leggi romane vi erano ugualmente osservate per tradizione, o come antiche usanze, ma non in qualità di leggi scritte. In tutto ciò nulla fu mutato da Ruggiero: quindi le leggi longobarde continuarono a essere in vigore. Volle però egli farne molte di proprie, nuove, adattate ai tempi e alle circostanze. Fattele, ordinò con un Editto che si osservassero in entrambi i Regni siciliano e pugliese. Di queste ci sono pervenute soltanto 39, inserite nel volume delle Costituzioni lasciateci da Federico II. In tal modo il diritto romano e molto più il longobardo si ebbero come diritto comune, le leggi di Ruggiero invece come diritto particolare. Egli ne fece anche alcune in materia feudale e di esse ce ne sono rimaste solo due.
Ruggiero volle anche introdurre gli uffici, cosiddetti ‘della Corona’, a somiglianza di quelli francesi, riguardanti non la persona del Re, ma l’ordinamento statutario del Regno. Questi uffici vennero ridotti a sette: del Gran Contestabile, del Grande Ammiraglio, del Gran Cancelliere, del Gran Giustiziere, del Gran Camerario, del Gran Protonotario e del Gran Siniscalco.
Nel 1144 Ruggiero ebbe tuttavia una controversia con Lucio Pp. II tale chw si venne alle armi. Invase egli allora lo Stato Pontficio e prese Terracina con altre località della campagna di Roma. Ma, fattasi la pace, il Pontefice concesse al Re altri onorevoli titoli, come quello di Legato della Sede Apostolica e ancor più favorì il rinsaldasi della monarchia meridionale. Concesse addirittura al Re insegne pontificali: l’anelllo, i sandali, lo scettro, la mitria e la dalmatica.
Ruggiero fece pure delle conquiste in Africa, Tolseal Re di Tunisi la città di Tripoli e altre ancora e si rese così colà potente che quel Re barbaresco, per averlo amico, si dichiarò suo tributario e per ben 30 anni pagò puntualmente il tributo promesso, noso solo a Ruggiero, ma pure a Guglielmo, di lui successore. Di questa sua impresa militare Ruggiero si gloriò tanto da far incidere sulla sua spada il seguente esametro:
APPULUS, ET CALABER, SICULUS MIHI SERVIT, ET AFER
Verso quel tempo, l’Imperatore Emanuele d’Oriente avendo trattato male ambasciatori di Ruggiero, questi gli mosse guerraù. Una forte armata, con numerosi vascelli, fu spedita al comando di Giorgio di Antiochia, suo Grande Ammiraglio, e molte importanti località furono tolte all’Imperatore bizantino, Ma, sopraggiunti all’armata imperiale validissimi rinforzi veneziani, Ruggiero stimò prodente non proseguire nella conquista e si accontentò d’aver fattoabbastanza conoscere la sua potenza a quegli Orientali. Dall’Albania e dalla Grecia ritornò in Sicilia e ne menò seco i maestri artefici di drappi di seta, i quali introdussero davvero quest’arte fra noi, sebbene in Italia essa non fosse del tutto ignota.
Ma tutti i vantaggi acquisiti con tanti stenti e fatiche marziali tolse a Ruggiero la morte sopravvenuta nel febbraio del 1154, non avendo egli che 58 anni.
Veramente fu un principe magnanimo e glorioso. Le sue gesta lo resero uno dei più potenti sovrani di quel tempo. Accorto in pace e valoroso in guerra, usò uguale costanza nell’avversa fortuna che moderazione nella prospera. Amico degli uomini di vaglia sia nelle armi che nelle lettere, utilizzò tanto il braccio di quelli quanto l’ingegno di questi e fu ugualmente liberale e cortese verso gli uni e gli altri. Fu generosissimo verso la Chiesa, ma nel tempo stesso molto incline agli amori femminili. Ben fatto nella persona e di grande statura, non meno dei suoi avi Vichinghi, aveva una voce imperiosa e risonante. Non lasciò altri figli legittimi che Cuglielmo, suo successore nel Regno e, postuma, Costanza, natagli dalla sua ultima moglie Beatrice. Questa Costanza, maritata trentenne con Enrico di Svevia, fu madre dell’Imperatore Federico II di Hohenstaufen e bisnonna di Costanza d’Aragona (v. Dante, Purg., III, 113). Lasciò anche un figlio naturale, il Conte Tancredi di Lecce.
I L REGNO SICULO-PUGLIESE DAL NORMANNO GUGLIELMO IL MALO ALLO SVEVO ENRICO VI L REGNO SICULO-PUGLIESE DAL NORMANNO GUGLIELMO IL MALO ALLO SVEVO ENRICO VI
G u g l i e l m o I, figlio di Ruggiero d’Altavilla, gli successe nel 1154 nel Regno siculo-pugliese, ma non certo nelle virtù del genitore. Di natura iraconda e feroce e avidissimo di denaro, non manifestò che vizi tali da farsi da tutti aborrire: gli stessi vizi che gli meritarono il sopranome di M a l o. Era già egli nel 1150 stato associato dal padre al trono ed era stato anche incoronato Re. Ma nel giorno di Pasqua del 1954 egli fece rinnovare la solenne cerimonia e ciò fece senza darne debita preventiva comunicazione ad Adriano Pp. IV, il quale per tale inaspettata condotta gli rifiutò l’investitura. Malgrado tale rifiuto, Guglielmo gli inviò un’ambasceria, con la quale si felicitava per l’essere egli succeduto a Papa Anastasio. Il Papa non rese che formali onori agli Ambasciatori e gli inviò a Salerno il Card. Ernesto con lettere credenziali, nelle quali non gli attribuiva il titolo di Re, ma di Signore della Sicilia. Di ciò indispettito, Guglielmo, congedato bruscamente il Cardinale, si avventò con un forte esercito sulle terre pontificie e occupò Benevento, Ceprano e altre località soggette al dominio della S. Sede. Dal suo canto, il Pontefice scomunicò Guglielmo e ne assolse i sudditi dal giuramento di fedeltà. Allora, alcuni malcontenti Baroni del Regno si schierarono dalla parte del Papa,rinforzato dalle truppe inviategli in soccorso dall’Imperatore dOriente, Michele Comneno, che tolse a Guglielmo buona parte dei domini al di qua del Faro.
Nell’anno 1155, quindi, i Bizantini riconquistarono le Puglie.
Ma Guglielmo raccolse tutte le sue truppe dalla Sicilia e ritornò con tanto impeto all’attacco che sconfisse i nemici, menando prigionieri in Sicilia. Ricuperate così, nel 1156, le terre pugliesi e scacciatine con loro disdoro i Bizantini, Guglielmo si umiliò al Pontefice e gli restituì le terre sottratte al dominio della Chiesa. Placato, il Pontefice lo assolse e gli concesse la tanto bramata investitura col titolo di Rex Utriusque Siciliae (Re dell’una e dell’altra Sicilia). Nello stesso tempo Guglielmo si obbligò a essere poi sempre il più deciso defensor Sanctae Ecclesiae.
Atti così giusti e pii avrebbero senza dubbio assicurato a Guglielmo un posto fra i migliori sovrani del suo tempo, s’egli stesso non si fosse di tanti vizi coperto e specialmente di quello che più avvilisce e degrada chi è destinato a governare. Questa detestabile colpa egli commise, allorché si diede tutto nelle braccia di un indegno ministro e si lasciò dal di lui volere signoreggiare. Era costui un tale Giorgio Majone, figlio d’un vile venditore d’olio, della città di Bari, e malgrado le origini plebee innalzato ai primi onori del Regno. Giunto a essere Notaio della R, Corte, ebbe la destrezza di insinuarsi talmente nel cuore del suo sovrano da tenerne dispoticamente le chiavi. Uomo di spregevoli costumi e di scaltro ingegno, tanto pronto a fingere, quanto accorto nell’ingannare, seppe tanto circonvenire Guglielmo che, giunto al grado di Grande Ammiraglio del Regno, ne divenne l’assoluto padrone . Per colmo di perfidia, egli giunse a insidiare il trono e il letto matrimoniale del suo signore. Profittando della smodata cupidigia di Guglielmo d’ammassare ricchezze, egli tanto denaro distrasse in suo profitto che non vi fu concussione o imposizione che non fosse da lui commessa per impadronirsi di tutto l’oro e l’argento della Sicilia, ove in poco tempo sparì perfino l’effigie delle monete al dire di quegl sfortunati sudditi.
Majone mirava alla sovranità. Ne fu il Re avvertito, ma mai volle crederlo, né almeno mettersi in guardia da lui. Molti Baroni e città si ribellarono apertamente. Majone, temendo che l’Arcivescovo Ugone di Palermo, suo complice nella congiura ordita contro il Re, non la svelasse, credette di allontanare il fulmine che già lampeggiava sul suo capo, col fare avvelenare lo stessoArcivescovo. Questi, avvedutosi d’aver bevuto una bevanda mortale, prima che la morte lo cogliesse fece pugnalare Majone da Matteo Bonello, che, sebbene di lui genero, lo odiava cordialmente. Il popolo palermitano fece strazio del cadavere dell’odiato Ministro. La Regina, che ne era stata la disonesta “amica”! e anche lei complice nella trama ordita contro la vita del Re, indusse Guglielmo a vendicarne la morte. I malcontenti, appresociò, arrestarono il sovrano e acclamarono loro Re il di lui figlio Ruggiero, appena novenne. Dopo tre giorni, per l’intervento degli Arcivescovi di Messina e Salerno e di altri ragguardevoli personaggi, il Re fu scarcerato; nel presentarsi a lui, tutto amorevole e lieto a lui il figlio, egli, credendo di vedere in essoi un rivale al trono, gli sferrò un calcio, colpendolo così violentemente al petto che quel bambino morì nelle braccia dell sua desolata madre. Di ciò lo stesso Guglielmo rimase poi inconsolabilmente amareggiato.
Nuove rivolte avvennero, fomentate da coloro che lo avevano imprigionato, né terminarono se non quando egli fece gettare Bonello in una oscura prigione, dove lo fece accecare e mutilare dei “tendini d’Achille”, onde poco dopo morì. Quindi Guglielmo passò nelle Puglie, ove con la forza e col terrore spense le ribellioni fomentate dai malcontenti e dai nemici di Majone. Riportata così la quiete nei suoi domini, egli se ne ritornò a Palermo, dalla quale i capi dei congiuraati espatriarono volontariamente, temendo di esporsi alle rigorose misure d’un Re vendicativo, da essi apertamente osteggiato. Altri furono dal Re esiliati e dopo ciò un altro pericolo egli corse di essere ucciso, o imprigionato, da un’orda di carcerati evasi. Egli li fece diligentemente ricercare e quindi severamente punire. Finalmente tranquillizzatosi, si diede all’ozio, finché morì, quarantaseienne, nel 1166.
Aveva Guglielmo emanato molte leggi, che si trovano collocate in vari titoli nella raccolta delle Costituzioni fatta da Federico II di Svevia. Fu uomo di aspetto nobile e maestoso e di statura ben al di là dell’ordinario, coraggioso e valoroso, ma smodatamente amico dell’ozio e incline a ogni vizio e assai più alla crudeltà.
G u g l i e l m o II, chiamato il B u o n o a causa degli ottimi suoi costumi, succedette al padre nel 1167, appena dodicenne, sotto la tutela di sua madre, Margherita di Navarra. La sua incoronazione avvenne nel duomo di Palermo con la maggiore solennità, alla presenza dei Prelati e dei Baroni del Regno. Margherita, per conciliare al figlio l’amore dei sudditi, ridusse le imposte, giunte ormai alla insopportabilità, ridiede la libertà a molti detenuti, richiamò dal bando tutti gli esiliati da Guglielmo I e restituì i loro beni ai Baroni. Poi Guglielmo, allorché giunse a reggere da solo il governo, abolì molti gravami fiscali e pose riparo a tutti i malfatti del genitore.
Guglielmo II prese in moglie Giovanna, figlia del Re Enrico II d’Inghilterra. Fu grande amico di Alessandro Pp. III, cui diede soccorso con denaro e con galere contro l’Imperatore Federico Barbarossa, il quale aveva cinto d’assedio Roma e meditava d’invadere le Puglie. In ricompensa di tali segnalati servizi, il Pontefice gli concesse l’investitura solenne del Regno.
Anche in Africa Guglielmo guerreggiò con valore e sconfisse, nel 1180, il Re del Marocco e nefece prigioniera la figlia, che non volle render libera se non quando gli furono rese le terre usurpate a suo padre. Si recò poi, nel 1185, con una formidabile armata nei Balcani per vendicare la strage che dei Latini aveva fatta a Costantinopoli il tiranno Andronico, quando aveva sottratto il trono imperiale ad Alessio. Guglielmo prese Durazzo, Salonicco e altre località, ma ne fu poi respinto dai Bizantini, i quali uccisero Andronico e diedero modo a Isacco l’Angelo di salire sul trono. Con questi Guglielmo fece quindi la pace e gli furono restituiti i suoi migliori capitani presi in questa campagna prigionieri.
Libero così da questa spedizione militare, attese a bene amministrare il Regno, interessandosi personalmente del più minuti affari dello Stato, delle finanze e dell’amministrazione della giustizia. Fondò molti monasteri e chiese e li dotò riccamente coll’immenso ammontare di denaro ritrovato nelle casse del padre. Mortagli la madre, la pianse inconsolabilmente. Morì immaturamente in età di soli 36 anni, nel 1189. Negli estremi momenti della sua vita Gugllielmo, in presenza di tutti i Grandi della Corte, dichiarò erede del trono Enrico di Svevia, allora Re di Germania, figlio dell’Imperatore Federico Barbarossa, cui poi successe nell’Impero, e marito di Costanza d’Altavilla, figlia postuma di Ruggiero, il fondatore della monarchia siculo-pugliese.
Il successore al trono, così destinato da Guglielmo il Buono, non ebbe il possesso delle due Sicilie, perché i Baroni del Regno e il popolo siciliano, aborrendo la dominazione di un principe straniero, chiamarono ed elevarono al trono, quarto loro Re, il Conte T a n c r e d i d i L e c c e, figlio naturale del Duca Ruggiero, primogenito del capostipite dlla dinastia premorto all’omonimo padre. Era egli un bastardo, perché generato fuor del matrimonio con una figlia del Conte Roberto di Lecce. Acclamato festosamente, eccetto che da molti Baroni pugliesi, fu solennemente incoronato in Palermo nel 1190 e Clemente Pp. III gli concesse presto l’investitura. Enrico, a tale notizia, spedì dalla Germania un esercito nelle Puglie, per sostenere con le armi i suoi diritti, nascenti dalla non equivoca disposizione di Guglielmo II. Ma, sconfitta dal Conte di Aversa, cognato e generale di Tancredi, l’armata tedesca si ritirò in Germania, in gran disordine.
Intanto Enrico, dopo la morte del padre Federico Barbarossa, Crociato (1190), volendo accattivarsi il favore dei suoi compatrioti, restituì al Duca di Sassonia e a ciascuno dei Principi Elettori tutto ciò che era stato tolto loro da suo padre. Sistemati in tal modo gli affari tedeschi, spedì a Roma Ambasciatori al Pontefice, avvertendolo che egli si disponeva a passare in Italia e chiedendo che lo incoronasse Imperatore inoccasione della prossima Pasqua. Infatti nella Pasqua del 1191 furono, con la solita pompa, incoronati sovrani del Sacro Romano Impero egli e la moglie Costanza, Di là passò nel Regno siculo-pugliese alla testa di una poderosa armata e, inoltrandosi per la via di Sora, si recò con Costanza a visitare la Badia di Montecassino, dove l’Abate Roffredo gli prestò omaggio e gli giurò fedeltà con tutti i suoi monaci e con quelli di S. Germano. Sottomessa tutta la Terra di Lavoro, il suo esercito avanzò fino a Napoli, ove incontrò validissima resistenza per pià giorni, Alla fine Aligerno, allora Governatore della città di Napoli, ispirato nei suoi ulteriore coraggio, costrinse Enrico a ritirarsi con l’esercito in Lombardia, lasciando la moglie Costanza a Salerno, ove l’aveva condotta. Alla necessità di questa ritirata egli, in verità, fu maggiormente costretto dal vedere le sue truppe attaccate da un morbo (peste o colera?) insanabilmente epidemico. Da esso afflitto l’esercito tedesco, l’armata di Tancredi prosperava e i Salernitani, per recuperare la di lui grazia, gli consegnarono l’Imperatrice Costanza. Tancredi però, a richiesta del Papa e anche perché essa era sua zia paterna, generosamente la rimandò con molti e ricchi doni al marito, che in fin dei conti era pure egli pertanto suo zio, in Germania. Di lì a poco, nel 1193 questo buon Principe morì, inconsolabile per la immatura morte di Ruggiero, suo primogenito.
Fu quindi G u g l i e l m o I I I, suo secondogenito, a succedergli al trono, nel 1194. Essendo ancora fanciullo, rimase però sotto il baliato di sua madre Sibilia, figlia del Conte Roberto di Aversa. A tali notizie, Enrico accorse nuovamente alla conquista del Regno, cosa che gli riuscì felicemente. Salerno, temendo la sua ira, per il suo comportamento nei confronti dell’Imperatrice Costanza, volle difendersi fortemente. Mal gliene incolse perché, non potendo più resistere alle forze imperiali, fu da Enrico presa e crudelmente saccheggiata. Molti cittadini furono uccisi, altri menati in orride prigioni, atri banditi, Tutte le altre città del Regno si sottomisero volontariamente. Indi, passato in Sicilia, incontrò la stessa accoglienza favorevole.
La Regina Sibilia, vedendo la infedeltà dei Siciliani e temendo per sé e per i suoi figli, abbandonata la reggia, si rifugiò nel Castello di Catalbellotta. Immediatamente, fu Enrico incoronato in Palermo e pensò d’aver ragione di Sibilia non con le ermi, ma con trattative. Così Sibilia cedette a Enrico tutte le regioni del Regno, riservando a lei il Contado di Lecce e al figlio Guglielmo il Principato di Taranto. Enrico pretese che formalmente il giovane Guglielmo deponesse ai suoi piedi la Corona di Sicilia. Così il dominio normanno passò alla stirpe degli Hohenstufen.
|



 RUGGIERO D’ALTAVILLA, DUCA DI PUGLIE E CALABRIE E FONDATORE DELLA MONARCHIA MERIDIONALE
RUGGIERO D’ALTAVILLA, DUCA DI PUGLIE E CALABRIE E FONDATORE DELLA MONARCHIA MERIDIONALE