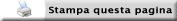|
 Ad un certo punto del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes fa pronunciare a Sancho Panza queste parole: «Nel mondo non c’è che due razze, diceva la mi’ nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha, e lei stava per quella di chi ha».Ebbene, queste stesse parole potrebbero apparire in epigrafe allo spettacolo Il razzismo è una brutta storia, scritto, interpretato e diretto da Ascanio Celestini, e presentato alla Galleria Toledo di Napoli, ennesima tappa di una tournée cominciata nel 2009, e immaginata e promossa dall’Arci, con la collaborazione della casa Editrice Feltrinelli, come campagna contro il razzismo. Ad un certo punto del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes fa pronunciare a Sancho Panza queste parole: «Nel mondo non c’è che due razze, diceva la mi’ nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha, e lei stava per quella di chi ha».Ebbene, queste stesse parole potrebbero apparire in epigrafe allo spettacolo Il razzismo è una brutta storia, scritto, interpretato e diretto da Ascanio Celestini, e presentato alla Galleria Toledo di Napoli, ennesima tappa di una tournée cominciata nel 2009, e immaginata e promossa dall’Arci, con la collaborazione della casa Editrice Feltrinelli, come campagna contro il razzismo.
E allora, è proprio il razzismo –o meglio, le tante storie di ordinario razzismo italiano- a costituire il nucleo concettuale da cui Celestini parte per sviluppare l’intero impianto scenico/narrativo, ma anche culturale e politico, che permea di sé lo spettacolo in parola. Un razzismo però, quello di cui ciparla l’autore, attore e regista romano, la cui essenza non è tanto la discriminante etnica, volta a garantire la purezza della razza –come nel caso del nazismo, per intenderci- ma una sorta di razzismo biologico/sociale/economico, incentrato sulla lotta di classe.
Parafrasando quanto scriveva Foucault a proposito della convergenza tra biopotere e razzismo, potremmo parlare, in questo caso, di un razzismo la cui idea di fondo è che l’altra razza non è la razza estranea, arrivata da chissà dove, ma è la razza che si riproduce continuamente all’interno della società. Non abbiamo più, pertanto, due o più razze avulse e contrapposte, ma lo sdoppiamento di una razza in una sovra-razza e in una sotto-razza, il cui esito è l’idea di una società biologicamente e culturalmente monista, frammentata in gruppi sociali sempre più esigui, all’interno della quale la minaccia è rappresentata da estranei che si sono infiltrati, elementi devianti o da sacche di emarginazione, consideratesottoprodotti della stessa collettività. Nasce così, come dicevamo in precedenza, un razzismo di matrice principalmente socio-economica, seppur non disancorato dalle vecchie concezioni biologiche, diverso però dal “razzismo etnico” di modello tradizionale. Il discorso, che tale razzismo mette in campo, non è più, infatti, quello della guerra tra gruppi etnici diversi, ma quello del conflitto di classe, all’interno del quale lo stato agisce come strumento della classe dominante. D’altronde, come ha dichiarato lo stesso Celestini in un’intervista rilasciata a Il Mattino: -Non siamo razzisti verso una rockstar di colore o verso i tedeschi che vanno d’estate a Rimini: perché? Perché non sono poveri. Facciamo finta che la lotta di classe non esista, ma non è vero[…]Nel momento in cui io sono al semaforo e c’è l’albanese, il rumeno, il marocchino che mi vuole lavare i vetri, la situazione che si crea è razzista-.
A questo punto, si comprende come la frase del Chisciotte, riportataall’inizio, sia quanto mai azzeccata, potendosi condensare, nella locuzione “la razza che ha”, tutto quanto abbiamo fin qui detto, e che costituisce poi la premessa e lo scopo dell’allestimento in analisi.
Con Il razzismo è una brutta storia, insomma, Celestini denuncia l’ordinaria intolleranza degli italiani che, come la nonna di Sancho Panza, stanno con chi ha, noncuranti della sorte della componente più debole e marginale della società -immigrata o italiana che sia- mettendo in atto anzi, nei confronti di questa, pratiche discriminatorie, fino al disprezzo e alla violenza; come discriminatori e violenti sono, del resto, gli strumenti normativi che codificano, legalizzandoli, tali comportamenti, e che per citare Alberto Burgio: -ci rimandano, per analogie e per somiglianze, alle pratiche di discriminazione e di persecuzione, legalizzate dalle politiche genocidiarie varate dai fascismi del ‘900-.
Se, dunque, la discriminazione può colpire indifferentemente, come abbiamo detto,italiani e immigrati, è pur vero che, mentre nel primo caso si può parlare solo di selettività classista, nel secondo caso agisce quella ostilità pregiudiziale verso lo straniero, che via via ha assunto, nel nostro paese ma non solo, i toni sempre più marcati e cupi di un vero e proprio razzismo, anche se su basi più che altro economiche. Un razzismo nutrito e avallato, sul piano sociale e culturale, da quei dispositivi di legge come la Bossi-Fini che, con l’introduzione di normative discriminatorie in materia di diritti politici, civili e sociali, ma anche, appunto, in campo contributivo e dei rapporti di lavoro, hanno finito per creare le premesse legali e culturali, nonché la giustificazione morale, per azioni violente e repressioni: dalle semplici manifestazioni di branchi razzisti, alla caccia all’uomo, anche da parte delle forze dell’ordine; dai rastrellamenti etnici, agli incendi dei campi nomadi, giù fino a quelli che si possono considerare veri e propri pogrom.
Insomma, diesempi riguardanti il razzismo della società italiana, sotto i nostri occhi, ce ne sono tanti, ahimè, ogni giorno.
Ascanio Celestini, con lo spettacolo in parola, ha deciso di raccontare il razzismo, e le sue molteplici facce, a suo modo. Lo ha fatto attraverso la narrazione di storie in cui si fondono, come sempre, il dato realistico -con il suo agghiacciante fardello di umano dolore, umana sopraffazione, umana umiliazione- e quella leggera, quasi impalpabile ironia, amara e surreale, che rende sopportabile allo spettatore lo stare ad ascoltare storie che, altrimenti, dovrebbero solo farci inorridire e provare vergogna per la nostra stessa condizione di “uomini evoluti”. Le storie che Celestini imbastisce, infatti, sono fulminanti spaccati di società, allegorie confezionate col gusto del paradosso e del grottesco, ma al cui interno si celano artaudiani frammenti di teatro della crudeltà, che Celestini lascia vivere attraverso monologhi densi di quell’arte affabulatoria, che fa delsuo teatro, un teatro popolare di narrazione, con chiari intenti civili, politici e militanti. Un genere che, prendendo le mosse dalle esperienze del monologo teatrale –vedi Mistero Buffo di Dario Fo- si è andato sempre più imponendo negli ultimi venti anni, annoverando autori/attori come Marco Baliani, Marco Paolini, Laura Curino, Gabriele Vacis e, più recentemente, Davide Enia, Mario Perrotta, Enrico Messina, Giulio Cavalli e, appunto, Ascanio Celestini.
Dunque teatro militante, quello di Ascanio Celestini, e perciò politico, che cerca di recepire elementi utili alla lotta politico-economica, e quindi alla lotta di classe, perseguendo, contemporaneamente, una nuova modalità di comunicazione teatrale. E ci riesce meravigliosamente, l’autore romano, in questo spettacolo, dove la musica -firmata da Matteo D’Agostino- si fonde al racconto orale, delineando una vera e propria drammaturgia della parola, che avvolge lo spettatore e, di attimo in attimo, lo incanta e lo scuote, lo avvincee lo respinge, lo ferisce e lo diverte. Le storie narrate da Celestini si susseguono fluide e senza sosta, dure nello svelamento dei diversi modi di essere razzisti, interrotte solo dalle dichiarazioni di due leghisti come Borghezio e Gentilini, il sindaco/sceriffo di Treviso. E sono dichiarazioni fatte nel corso di comizi pubblici, che fanno accapponare la pelle per la loro infiammata retorica, satura di violenza razzista. Sono gli unici documenti usati all’interno dello spettacolo, quasi a ratificare, con la loro irruzione, la necessità di quel momento teatrale. Del resto, ed è un parere del tutto personale, il teatro -come l’arte in genere- ha un senso solo se è necessario, vive cioè non slegato dalle dinamiche della realtà che lo circonda, rileggendola in chiave dialettica e critica, non mimetica.
Il razzismo è una brutta storia ha dunque un senso perché è uno spettacolo necessario: necessario per la nostra cultura declinante, per le nostre coscienze assopite, per le nostrepassioni politiche congelate. Per questo, quando alla fine grandi applausi hanno accolto Celestini al proscenio, un pensiero mi ha attraversato la mente: speriamo che –e non voglio fare della retorica pessimista- lo spettacolo non sia stato una specie di lavacro purificatore per le nostre coscienze di sinistra, una volta finito il quale possiamo tornare alla tranquillità delle nostre esistenze borghesi, immersi nell’artificiosità della realtà televisiva, senza nulla fare perché l’attuale situazione cambi!
Del resto, viviamo nella società dello spettacolo –per citare il mitico volume di Guy Debord- dove tutto è ormai diventato merce/illusione: la cultura, la politica, la giustizia, il lavoro, le guerre, l’informazione e la vita stessa, con i suoi gesti e le sue passioni depotenziate e ridotte al rango di scadenti rappresentazioni. Anche il razzismo ovviamente, ce lo ricorda lo stesso Celestini nel corso dell’allestimento, è diventato spettacolo. E allora, a questo riguardo, mi sipermetta di chiudere con una citazione -tratta dall’introduzione di Carlo Freccero proprio a La società dello spettacolo- che dovrebbe suonare come un monito,: -Solo il fragile scudo della rivoluzione separava una generazione dall’integrazione nello spettacolo. Quel feticcio è caduto, cancellato dal potere della stessa società spettacolare[…]La rivoluzione è morta mentre lo spettacolo è diventato l’episteme del nostro tempo. Lo spettacolo ha vinto perché è in grado di assorbire qualsiasi forma di opposizione facendola propria. Non possono esserci spettacoli contro!-. Lo spettacolo teatrale di Celestini, invece, è contro per definizione. Menomale! Vincenzo Morvillo
|



 Ad un certo punto del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes fa pronunciare a Sancho Panza queste parole: «Nel mondo non c’è che due razze, diceva la mi’ nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha, e lei stava per quella di chi ha».Ebbene, queste stesse parole potrebbero apparire in epigrafe allo spettacolo Il razzismo è una brutta storia, scritto, interpretato e diretto da Ascanio Celestini, e presentato alla Galleria Toledo di Napoli, ennesima tappa di una tournée cominciata nel 2009, e immaginata e promossa dall’Arci, con la collaborazione della casa Editrice Feltrinelli, come campagna contro il razzismo.
Ad un certo punto del Don Chisciotte, Miguel de Cervantes fa pronunciare a Sancho Panza queste parole: «Nel mondo non c’è che due razze, diceva la mi’ nonna, quella di chi ha e quella di chi non ha, e lei stava per quella di chi ha».Ebbene, queste stesse parole potrebbero apparire in epigrafe allo spettacolo Il razzismo è una brutta storia, scritto, interpretato e diretto da Ascanio Celestini, e presentato alla Galleria Toledo di Napoli, ennesima tappa di una tournée cominciata nel 2009, e immaginata e promossa dall’Arci, con la collaborazione della casa Editrice Feltrinelli, come campagna contro il razzismo.